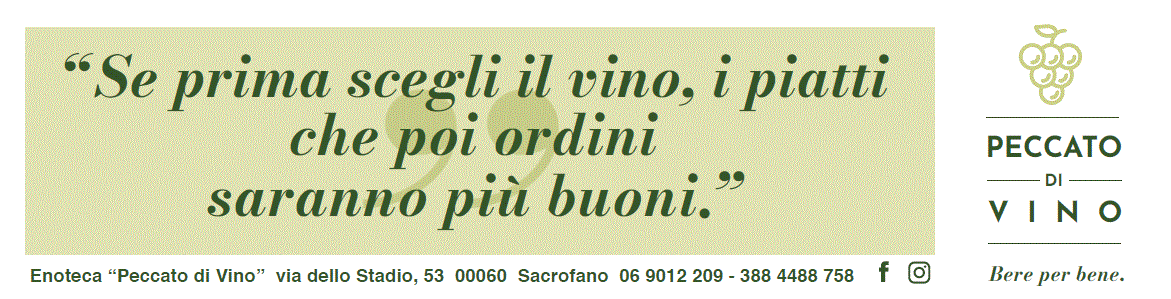L’editoriale
A Sacrofano i conti tornano, ma per alcune attività commerciali è previsto l’aumento della Tari
Scongiurato il dissesto, Il Comune ritrova l’equilibrio finanziario e si appresta a pagare la prima rata concordata con i creditori dell’ex RSA
di Marco Ferri
Non ci sono problemi per il pagamento della prima rata delle tre previste dalla transazione con i legali dell’ex Consorzio Siria, che ha vinto la causa contro il Comune per la nota vicenda della RSA. Essendo stato allontanato lo spettro del dissesto, che avrebbe comportato il commissariamento delle entrate e la soppressione di alcuni servizi essenziali per i cittadini, il 9 giugno il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione dello stato patrimoniale e del conto economico nel 2024. È stato approvato anche l’avanzo di amministrazione di esercizio, che testimonia il fatto che i conti sono finalmente in equilibrio. Senza mai dimenticare che ogni sei mesi, fino al 2030, bisogna comunque riferire alla Corte dei Conti il flusso delle entrate e delle uscite. Ci sono, invece, novità sul fronte delle tariffe. Secondo quanto predispone ARERA ci sarà un adeguamento dei costi relativi alla raccolta differenziata. Attraverso un procedimento che viene definito PEF, cioè Piani Economici-Finanziari, il Comune si deve adeguare le direttive dell’ARERA, che è un’autorità indipendente dello Stato che regola e controlla, tra l’altro, il sistema della raccolta dei rifiuti urbani. Secondo quanto prevista dal PEF, la società Tekneko, che ha in appalto comunale il servizio della raccolta porta a porta, a sua volta deve adeguare i servizi offerti tenendo conto anche della maggiorazione dei suoi costi di gestione. Per tanto, il Comune si trova di fronte a un maggior esborso verso la Tekneko, e di conseguenza dovrà aumentare in proporzione la TARI, che è bene ricordare non entra nelle casse comunali, perché va interamente dedicata all’efficientamento della raccolta dei rifiuti. La Tari per le utenze domestiche rimarrà invariata, anche se le rate passeranno da cinque a tre. L’aumento è previsto per specifiche categorie di esercizi commerciali, per le voci che riguardano i costi variabili della tariffa, cioè le quantità degli scarti da raccogliere, la metratura dei locali, la tipologia delle attività o il numero di pasti serviti: gli alberghi, i ristoranti, i bar, negozi di ortofrutta e pescheria, che sono gli esercizi che si è calcolato producano abbondanti scarti nell’umido, per via del numero dei clienti serviti. Il criterio si applica anche alle mense delle case di riposo. Dunque, il principio prevede una rimodulazione dei costi variabili in senso progressivo. In sostanza si applicano due criteri: si paga di più a seconda del calcolo dei rifiuti prodotti che a sua volta è ricavato sia dalla metratura dei locali, sia dal numero degli ospiti che vengono serviti ogni giorno. Secondo quanto previsto dal PFE del Comune, mentre la parte fissa dei costi è in diminuzione, l’aumento dei variabili si aggira complessivamente sui ventimila euro, che dovranno essere segmentati e spalmati nelle prossime tariffe TARI, con differenti percentuali, tra le categorie economiche prese in esame. Sia per le utenze domestiche che per gli esercizi commerciali, quest’anno la TARI dovrà essere versata in tre rate: ad agosto, a ottobre e a dicembre 2025. Non stupisce che gli aumenti non saranno affatto graditi ai cittadini né che diano luogo a facili polemiche politiche, con le quali però non si esce dagli obblighi di legge, a meno che non succeda quello che è successo per lungo tempo, cioè far figurare in bilancio entrate che però non erano state ancora riscosse. Però è proprio per questo che ancora i cittadini di Sacrofano pagano la Tari nella massima percentuale, cui si aggiunge il perdurare dell’evasione, in parte riassorbita, ma che comunque rasenta ancora il 50 per cento. Per dirla in soldoni, visto che di soldi si tratta: chi non paga fa pagare di più chi paga regolarmente. Tuttavia, a quanto ci risulta, l’Ufficio Tributi conferma la disponibilità a rateizzare i pagamenti insoluti.
Come eravamo
Quando l’acqua a Sacrofano era nell’età del rame
Dopo un inverno passato a fare lo slalom tra i semafori mobili che segnalavano lavori stradali di rifacimento delle condutture dell’acqua, ecco un “come eravamo” ai tempi in cui le case di Sacrofano non avevano ancora acqua corrente
di A. I.
Lastroni bianchi, levigati, corrosi dall’acqua della fonte, belli da vedere e da toccare. Una sensazione di piacere e di ristoro. Laggiù nella lunga e stretta valle, ai piedi del Monte Gennaro, ricca di orti rigogliosi e di calle dai bianchi imbuti, di dalie e zinnie colorate, si ergeva il Lavatoio Pubblico. Una costruzione oggi abbandonata, priva della sua acqua cristallina e canterina rimasta laggiù nel grande piazzale ormai trasformato in un vasto parcheggio arido e triste e poco utilizzato perché troppo scomodo per risalire la ripida ed erta strada. Quel Lavatoio un tempo si animava dalla continua presenza delle donne: voci, chiacchiere, canti, acqua freschissima e pulita, bucati da lavare, sbattere, passare nella cenere e poi nella saponata, poi risciacquati con cura e infine torti perché otessero essere trasportati nelle ceste. La voglia in estate di tuffarsi nelle vasche colme era una attrazione irresistibile. ma non si poteva: l’acqua era un bene troppo prezioso per poterlo imbrattare e inquinare. Bisognava avere rispetto e consapevolezza di quella ricchezza da non sprecare e preservare in tutta la sua purezza. La fonte laggiù a Pie’ di Pozza era soprattutto preziosa perché forniva l’acqua per bere. Per molti anni dopo la fine della guerra, le case erano sprovviste di impianti d’acqua potabile. Ci si lavava o si cucinava o si faceva pulizia con l’acqua dei cassoni o piovana recuperata o dei pozzi laddove esistevano. Ma per bere si usavano delle bellissime conche di rame battuto, panciute in fondo e snelle nella parte superiore, con grandi manici ritorti, alcune ricche di decori a sbalzo. Grandi e pesanti. Le donne scendevano presto al mattino o prima del tramonto (secondo le stagioni), riempivano sotto il getto generoso della bocca d’acqua corrente le lucide e rossastre conche e poi, aiutandosi l’una con l’altra, preparavano “le coroje” ovvero degli strofinacci di cotone spesso, ne facevano un torcione che arrotolato su stesso diventava una vera corona da porre sul capo. La parte difficile era abbassarsi fino all’orlo della fonte, prendere le conche per i manici, issarle sulla corona in cima alla testa e rialzarsi lentamente per non sbilanciare il peso ed evitare di far esondare l’acqua o peggio cadere. Erano delle dee. Movimenti perfetti, sincronizzati, con uno sforzo fisico immane si alzavano e con una mano sul fianco e l’altra a tenere il manico della conca, salivano con eleganza e fierezza su per la ripida salita che sfociava sulla strada di mezzo. È troppo romantico dire che sembravano delle indossatrici a una sfilata tanto erano eleganti. La fatica segnava i loro volti, le loro spalle, le loro braccia. Donne eroiche che quasi ogni giorno ripetevano, senza troppi lamenti, questo obbligo sfinente. La conca una volta in casa, troneggiava in un angolo della cucina, chiusa da un coperchio di legno, con accanto un ramaiolo appeso a un chiodo con cui si pescava l’acqua fresca e generosa senza sprecarla mai. Alle bambine venivano regalate delle piccole conche come fosse un giocattolo ambito ma soprattutto perché prendessero confidenza con quel lavoro da imparare e tramandare. Certo vedere oggi lo spreco che si fa dell’acqua senza alcuna remora né cura fa male al cuore. Impianti obsoleti, perdite quasi fiumi d’acqua che si riversano sulle strade nell’indifferenza e con un’insopportabile lentezza nel porvi rimedio. Annaffiature di orti, balconi, pulizie che potrebbero essere fatte in altro modo eliminando tanto spreco. Sarebbe utile ripensare a come raccogliere in invasi, cassoni, cisterne le acque piovane che ormai arrivano come cicloni causa il surriscaldamento del clima. L’acqua è vita e il pensiero va a quelle donne che dovrebbero far riflettere su quanto siamo fortunati ad aprire un rubinetto e veder scendere quel liquido così prezioso, buono e insostituibile. Pensiamoci.
Giacomo Matteotti, Sacrofano non dimentica

(Foto di Romeo Marcori)
Il 22 maggio scorso i giardini pubblici sono stati ufficialmente intitolati a Giacomo Matteotti, deputato socialista rapito e assassinato da una banda di sicari fascista il 10 giugno del 1924. Alla cerimonia hanno preso parte Patrizia Nicolini, sindaca di Sacrofano; Francesco Mancini, sindaco di Magliano Romano; Luca Abbruzzetti, sindaco di Riano Flaminio. Con la conduzione di Gabriella Gandellini, sono intervenuti Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Giacomo Matteotti e Sandro Ruotolo, europarlamentare; Samuele Di Donato, sindaco del consiglio delle ragazze e dei ragazzi; Sara Martone, sindaca del consiglio delle bambine e dei bambini. Folta la presenza degli alunni dell’IC Pitocco, accompagnati dalla vicepreside, professoressa Adele Cantoni.
Nel prossimo numero
 Una nuova rubrica di Adriano Braidotti, uomo di teatro, per capire le potenzialità del Teatro Ilaria Alpi nell’ottica della costruzione di un circuito teatrale tra i comuni della Città Metropolitana a nord di Roma.
Una nuova rubrica di Adriano Braidotti, uomo di teatro, per capire le potenzialità del Teatro Ilaria Alpi nell’ottica della costruzione di un circuito teatrale tra i comuni della Città Metropolitana a nord di Roma.
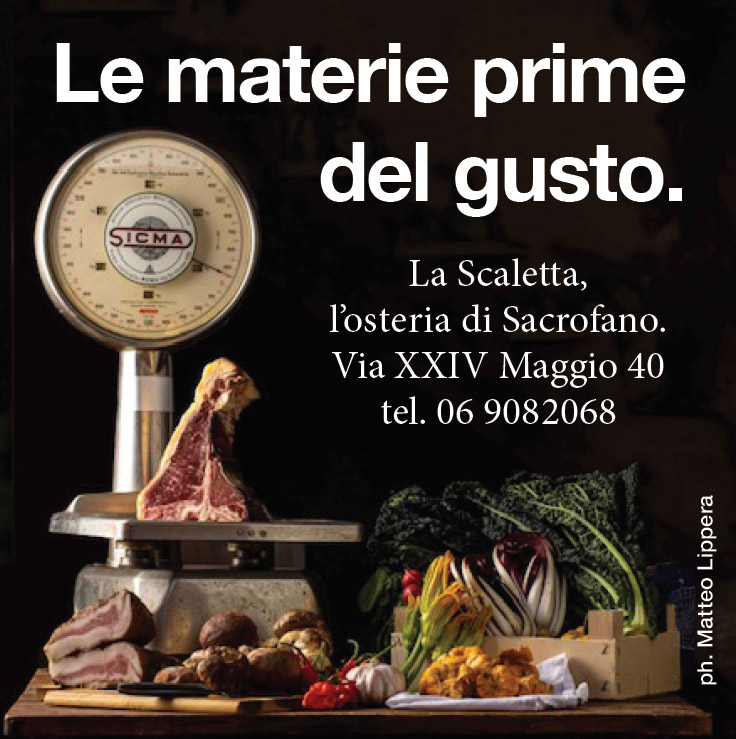
Usi civici, le Università di Sacrofano al microscopio
Negli ultimi anni, ci sono state discussioni e controversie riguardanti la gestione e la legittimazione degli usi civici a Sacrofano. Ad esempio, nel 2022 è stato presentato un ricorso al Commissario per gli Usi Civici della Regione Lazio da parte dell’Università Agraria di Sacrofano. Queste iniziative riflettono l’importanza di aggiornare e chiarire la normativa relativa agli usi civici per garantire una gestione equa e sostenibile delle risorse collettive. Contemporaneamente ci dicono quanto siano importanti gli usi civici per la gestione delle risorse del territorio e la sostenibilità delle attività relative all’agricoltura e all’allevamento. Senza lasciare indietro il fatto che il modo in cui queste attività si svolgono influisce direttamente sulla qualità della vita di chi abita, vive e lavora a Sacrofano. Cominciamo la riflessione su questi temi prendendo in esame gli usi civici e le attività dell’Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano. Nel prossimo numero approfondiremo l’analisi con l’Università Agraria di Sacrofano e con il Comune di Sacrofano.
L’analisi
L’importanza, il ruolo e la funzione dell’Università Possidenti di Bestiame di Sacrofano
Un incontro a tutto campo con Enrico Granori, presidente ed Edoardo Serata, vicepresidente
di Simone Bianchini e Marco Ferri

A Sacrofano esistono due enti distinti che gestiscono i diritti di uso civico sul territorio: l’Università Agraria di Sacrofano e l’Università dei Possidenti di Bestiame di Sacrofano. Entrambi sono enti pubblici non economici, ma hanno funzioni e competenze differenti. Gli usi civici a Sacrofano rappresentano una forma storica di diritti collettivi esercitati dalla comunità locale su determinati terreni. Se chi vive o semplicemente visita Sacrofano rimane colpito dalle vaste aree di verde, è proprio perché alcune centinaia di ettari di terreno sono vincolati, parte all’agricoltura e parte all’allevamento. I due enti, – degli agrari e degli allevatori – svolgono oggettivamente un ruolo di salvaguardia degli usi civici, utile non solo a chi coltiva la terra e alleva bestiame, ma anche a chi vive e lavora nel territorio, perché – pur la dove si riscontrassero difetti di gestione- la loro presenza garantisce la tutela di quel patrimonio di inestimabile valore che è il verde pubblico, la grande attrattiva di Sacrofano, dove, oltre alle due Università, ha sede anche il Parco di Veio. Qui prendiamo in esame l’Università dei Possidenti di Bestiame di Sacrofano, ente pubblico non economico che si occupa principalmente dell’allevamento del bestiame allo stato brado e della tutela dei beni di uso civico, come previsto dalla legge 1766/1927. Come ci spiegano Enrico Granori e Edoardo Serata, rispettivamente presidente e vicepresidente, si chiama Università perché con “universitas” “in diritto romano, viene indicata una pluralità di cose, di persone o di rapporti giuridici: personarum, la persona giuridica a struttura corporativa” (dal vocabolario Treccani). Dunque, non è un’università accademica nel senso tradizionale, ma un ente pubblico non economico con una lunga storia legata alla gestione dei beni collettivi e degli usi civici nel territorio di Sacrofano. Ma di cosa si occupano gli aderenti all’Università dei possidenti? Innanzitutto, di fida pascolo, la tassa per l’esercizio del diritto di uso civico del pascolo che un proprietario di bestiame deve versare per far pascolare i propri animali su un terreno collettivo: è l’ente che stabilisce annualmente le sezioni boschive nelle quali è possibile svolgere la fida pascolo e il numero di capi da immettere nei pascoli stessi. Poi, c’è l’attività di regolamentazione del pascolo: poiché sono ammessi alla fida pascolo nei fondi dell’ente esclusivamente bovini ed equidi, il bestiame deve essere identificabile tramite marca auricolare o microchip, e i proprietari devono presentare la documentazione richiesta prima dell’immissione al pascolo. Infine, la gestione dei beni di uso civico: l’ente si occupa della tutela e della gestione dei beni di uso civico, garantendo il rispetto delle normative vigenti e promuovendo pratiche sostenibili di allevamento. Edoardo Serata ci ricorda che l’Università Possidenti di Bestiame ha radici storiche profonde: fu fondata infatti nel 1704, poco dopo la cessione del feudo degli Orsini alla famiglia Chigi. Nel corso dei secoli, l’ente ha mantenuto la sua funzione di gestione collettiva dei diritti di pascolo, evolvendosi fino a ottenere la personalità giuridica di diritto privato secondo la Legge 20 novembre 2017, n. 168. Secondo il presidente Granori, attualmente l’Università Possidenti di Bestiame gestisce circa 200 ettari di terreni, su cui pascolano, a seconda della natalità, circa 300 capi di bestiame bovino ed equino, allevati allo stato brado su terreni ancora immuni da ogni forma di inquinamento. In realtà di cavalli a Sacrofano ce ne sono molti di più, basti pensare alla florida attività dei maneggi e all’addestramento per le attività legate agli sport equestri, ma di questo ci occuperemo in seguito. Per quanto riguarda gli allevatori, i membri dell’Università Possidenti di Bestiame attualmente sono 20 soci che si occupano di bovini e 20 utenti che si occupano di equini.
Era un diritto, è diventato un divieto: restituire agli usi civici la libertà di essere un bene comune condiviso
di Piero Santonastaso
Roma, quartiere Trieste, via Tronto 2. Qui c’è la sede del Commissariato agli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, organo giurisdizionale speciale istituito con legge del 1927, che decide sulle controversie legata al godimento dei diritti collettivi come il pascolo e la caccia su terreni appartenenti ai Comuni o a terzi. Le sue decisioni sono appellabili presso una sezione specializzata della Corte di Appello di Roma, competente per tutti i 14 commissariati del territorio nazionale, Sicilia esclusa. È in via Tronto che ovviamente si decidono anche le controversie di Sacrofano, la cui storia è strettamente legata agli usi civici del territorio, perpetuando il concetto di proprietà collettiva della terra che in Italia e non solo si era affermato a partire dal secondo millennio avanti Cristo. Un concetto che slittò gradualmente di significato, trasformandosi in una sorta di diritto alla sopravvivenza. Infatti, fin dalla nascita nell’VIII secolo del fundus Scrofanum, parte della più ampia domusculta Capracorum (vastissima tenuta agricola istituita nel 780 da papa Adriano I ed estesa da Veio a Nepi), la vita di contadini e braccianti – i servi della gleba di scolastica memoria, quando non addirittura schiavi – era legata alla capacità di sfruttare le risorse naturali del territorio. I prodotti delle coltivazioni e degli allevamenti andavano alla Chiesa (inizialmente la romana Santa Maria in Cosmedin) e al dominus, il padrone, mentre una parte in quota fissa era destinata ai poveri di Roma. Ai lavoratori sul territorio restavano le briciole, giocoforza integrate con i frutti della terra. Nacquero così gli usi civici, cioè il diritto di attingere liberamente alle risorse naturali, che saranno codificati nei secoli successivi al Mille, quando Sacrofano comincerà a essere menzionata come castello di proprietà della diocesi di Selva Candida. Ecco dunque il “legnatico”, la facoltà di fare legna nei boschi; il “frondatico”, quella di raccogliere fronde; “pascolatico” ed “erbatico”, il diritto di pascolare mandrie, greggi e singoli capi di bestiame; “fungatico”, la possibilità di andare a funghi; “spigolatico”, il diritto a spigolare tra le messi. La selvaggina era per antica tradizione res nullius, cioè di nessuno, e solo nel Basso Medioevo arriveranno i divieti legati alle tenute reali e papali. C’erano però delle limitazioni: l’uso civico era un diritto della collettività stanziale, non dei singoli di passaggio o dei gruppi di recente insediamento. Inoltre, era il feudatario locale, a nome del sovrano, il proprietario delle terre e di chi vi abitava, ed era perciò lui a decidere quali aree aprire al libero sfruttamento, di solito porzioni ridotte del territorio. Con corollario di abusi costituito dalle “difese”, recinzioni più o meno naturali con le quali i signori recintavano i terreni per sottrarli all’uso della collettività. A Sacrofano il controllo degli usi civici spettò dal XIII secolo e in ordine cronologico, ai Prefetti di Vico (non una carica ma una famiglia antipapato legata ai Corsi e ai Papareschi di Roma), poi per quasi tre secoli (1375-1662) agli Orsini di Bracciano (uno degli undici rami della famiglia), finché Francesco Orsini in bancarotta dovette cedere il feudo ai Chigi. Si arrivò così all’alba del XIX secolo, quando un singolare incrocio tra le legislazioni napoleoniche che sostenevano l’iniziativa liberista e le leggi eversive della feudalità promosse da alcuni sovrani, accrebbero la confusione in materia, in una sorta di tutti contro tutti. Si dovette attendere lo stato unitario perché nel 1888 fosse varata la legge Bonelli che istituiva le università agrarie, titolari della gestione dei diritti collettivi sui terreni di proprietà pubblica. A Sacrofano, dove dal 1705 esisteva l’Università dei possidenti di bestiame (UPB), nel 1909 sulla scorta di quella legge nacque l’Università agraria (“università” è denominazione esclusiva degli ex stati pontifici, altrove si chiamano diversamente) dei domini collettivi, che oggi gestisce circa 330 ettari, parte dei quali ricadenti nel territorio del Comune di Roma, cui si aggiungono i circa 200 nella disponibilità di UPB. Il panorama però è completamente cambiato: oggi l’uso civico da diritto si è trasformato in vincolo, introdotto con la legge Galasso del 1985 (tutela dei beni paesaggistici) per contrastare le occupazioni abusive. Di fatto, una situazione ingessata che avrebbe bisogno di una revisione legislativa, per restituire agli usi civici la loro funzione originaria.
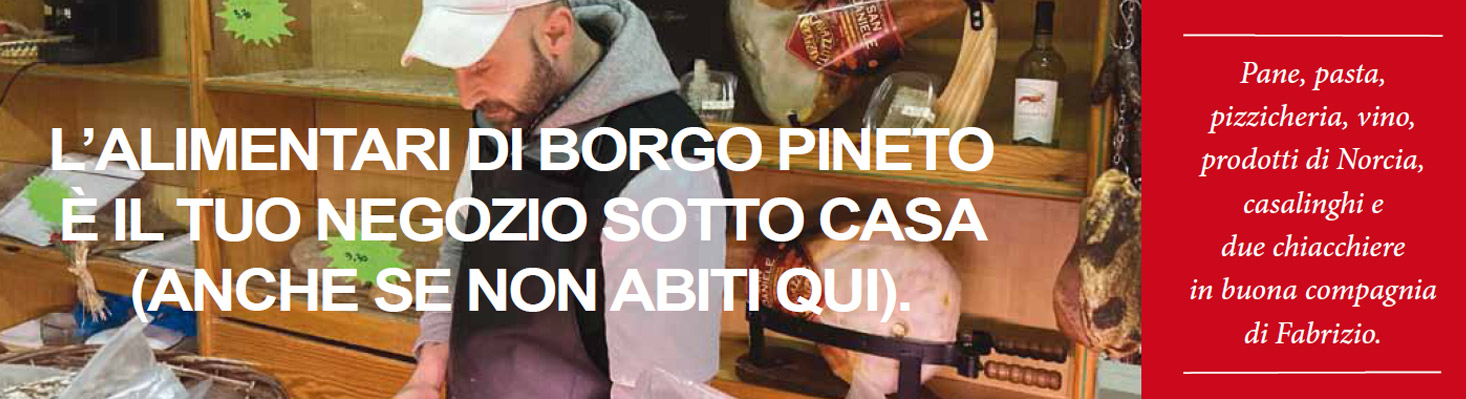
La recensione
Reinas
In attesa che si attivi una sala cinematografica presso il Teatro Ilaria Alpi, ecco la recensione di un film che ci sarebbe piaciuto vedere a Sacrofano
di Riccardo Tavani

In spagnolo Reinas significa Regine, e con un breve apologo nella locale lingua quechua termina il film: “I piedi per terra, gli occhi al cielo e niente è impossibile”, dice il padre delle due giovani regine di Lima, protagoniste della storia. Sembra quasi “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me” di Kant. Il film è ambientato in Perù agli inizi degli anni ’90, e descrive anche la situazione che viveva in quel momento il Paese. Sono proprio gli anni in cui si è formato l’attuale pontefice Papa Leone XIV, essendo stato via via, in vent’anni, Parroco, Priore, Prefetto, Docente, Direttore del Collegio Agostiniano, Giudice del Tribunale Ecclesiastico, Nunzio Apostolico con cittadinanza peruviana. Ha così toccato con mano la povertà, l’inflazione alle stelle, la dura repressione di polizia, il coprifuoco notturno contro l’opposizione di Sendero Luminoso e altri gruppi che agivano anche attraverso attentati dinamitardi. Proprio in quelle stesse precarie, tanto indefinite quanto indefinibili condizioni economiche e sociali versa il padre delle due ragazze, che hanno però una madre e una nonna di famiglia borghese mediamente agiata. Sono tante le famiglie di questo tipo che a malincuore in quel periodo se ne vanno via, cercando riparo e lavoro in zone della provincia Usa. Il tema drammatico dell’allontanamento è qui giocato in chiave anche di commedia, attraverso la figura di questo padre messo male in arnese, che si arrangia come può, con doti istrioniche d’attore, per mezzo delle quali cerca di recuperare con le figlie un rapporto ormai quasi del tutto perduto. Proprio come tenta in quegli anni il Perù. Premio Miglior Film alla Berlinale Sezione Generation. Premio del Pubblico a Locarno. Distribuzione ExitMedia. Data di uscita:15 maggio 2025; Genere: Drammatico; Anno: 2024; Regia: Klaudia Reynicke; Attori: Abril Gjurinovic, Luana Vega, Jimena Lindo, Gonzalo Molina, Susi Sánchez, Denise Arregui, Fabrizio Aguilar, Tatiana Astengo, Sebastián Rubio, Uma Mikati Paese: Svizzera, Perù, Spagna; Durata: 104 min.
Ex Libris
Ex Libris
a cura di M.F.
Conosci te stesso

L’espressione “conosci te stesso” è stata ripetuta abbastanza spesso, e in essa si è vista la meta di tutti gli sforzi dell’uomo. È giustissimo, ma è ugualmente certo che non può essere la meta se non è anche il principio. L’individuo etico conosce sé stesso, ma questa conoscenza non è solo contemplazione (perché allora l’individuo si coglierebbe soltanto secondo la sua necessità), è una riflessione su sé stessi, che in sé è azione, e perciò di proposito ho scelto l’espressione scegliere sé stessi invece che conoscere sé stessi. Quando l’individuo conosce sé stesso non ha finito, al contrario, questa conoscenza è assai feconda, e da questa conoscenza esce il vero individuo. Se volessi essere direi che l’individuo conosce sé stesso come nel Vecchio Testamento è detto che Adamo conobbe Eva. (Sören Kierkegaard, “Aut-aut” Mondadori 2025).
Il racconto
Il silenzio delle sirene
Una dimostrazione di come risorse insufficienti e persino puerili possano costituire comunque un mezzo di salvezza – (di Franz Kafka)
Per difendersi dalle sirene, Ulisse si tappò le orecchie con la cera e si fece incatenare all’albero della nave.Qualcosa del genere, certo, avrebbero potuto fare fin dai tempi remoti tutti i viaggiatori, a parte quelli che le sirene riuscivano a sedurre anche da lontano; ma si sapeva ovunque che era impossibile che questo rimedio funzionasse. Il canto delle sirene pervadeva ogni cosa, e la passione dei sedotti avrebbe spezzato lacci più forti di catene e alberi. Ulisse, anche se forse ne era consapevole, non ci pensò. Confidò pienamente nella sua manciata di cera, nel suo mazzo di catene, e con gioia innocente, tutto contento delle sue piccole astuzie, navigò incontro alle sirene. Ma le sirene dispongono di un’arma ancora più terribile del loro canto. Il loro silenzio. Forse si poteva concepire – anche se, certo, neanche questo era accaduto – che qualcuno riuscisse a salvarsi dal loro canto; ma nessuno, non v’è dubbio, poteva salvarsi dal loro silenzio. Niente di terreno potrebbe resistere alla sensazione di averle vinte con le proprie forze, all’incomparabile esaltazione conseguente. In effetti, all’arrivo di Ulisse, le formidabili cantatrici non cantarono, sia perché ritennero che un tale avversario potesse essere affrontato soltanto col silenzio, sia perché vedere quella beatitudine sul volto di Ulisse, che non pensava ad altro che a cera e catene, le rese dimentiche di qualsiasi canto. Ma Ulisse, per così dire, non sentì il loro silenzio; credeva che cantassero, e che lui soltanto fosse preservato dal sentirle. Vide in primo luogo, fugacemente, le torsioni dei loro colli, la respirazione affannosa, gli occhi colmi di lacrime, la bocca socchiusa e credette che tutto ciò facesse parte delle melodie che, non udite, risuonavano e si perdevano intorno a lui. Ma tutto questo rimbalzava appena sul suo sguardo assorto; era come se le sirene scomparissero di fronte alla sua determinazione, e proprio quando era più vicino a loro, non sapeva più nulla della loro presenza. Loro invece – più belle che mai – si stiravano e si contorcevano, allungavano gli artigli aperti sopra lo scoglio e le orride chiome ondeggiavano al vento, libere. Non miravano più a sedurre; volevano solo catturare, finché fosse stato possibile, il riflesso dei grandi occhi di Ulisse. Se le sirene avessero coscienza, quella volta sarebbero state distrutte. Ma resistettero, e solo sfuggì loro Ulisse.
Del resto, la tradizione riferisce anche un epilogo al riguardo. Ulisse, si racconta, fu così volpe, così ricco di astuzie, che nemmeno la dea del destino riuscì a penetrare il suo animo. Forse – per quanto sia inconcepibile per la ragione umana – si accorse davvero che le sirene tacevano, e solo come scudo, per così dire, oppose a loro e agli dèi tale finzione.
Il verso giusto
Ambizione
a cura di Monica Maggi

Nulla di più, Poesia:
la grazia più alta è nel fiore cupo
che dona tutta la sua essenza.
Non cercare altro.
Taglia, abbrevia, riassumi, Non volere che la rosa dia più del tuo profumo!
(da Poesie, 1924)
Jaime Torres Bodet
(Città del Messico, 17 aprile 1902 – 13 maggio 1974), poeta, scrittore e politico messicano. Più volte ministro, fu direttore generale dell’UNESCO e ambasciatore in Francia. La sua poesia ha un accento sapido e malizioso grazie al quale egli non cadde mai in effetti facili o gratuiti.

La comunità
Ecco come hanno votato gli elettori romeni alle ultime elezioni
Nelle ultime elezioni presidenziali in Romania – svoltesi con il primo turno il 4 maggio 2025 e il ballottaggio il 18 maggio 2025 – ha vinto Nicușor Dan, sindaco di Bucarest, con circa il 53,6 % dei voti, battendo il nazionalista George Simion, che ha raccolto il 46,4 %. La partecipazione degli elettori è stata alta e la direzione del voto ha segnato una svolta significativa
di Cristina Cotarta
In Italia, dove si trova la più grande comunità romena al di fuori del paese, con più di un milione di persone, hanno votato oltre 50.000 persone in più rispetto all’autunno scorso. Nel novembre del 2024, al primo turno, c’erano stati poco più di 123.000 elettori, mentre il 4 maggio 2025 sono andati alle urne quasi 175.000 aventi diritto al voto. La “Diaspora romena” ha avuto una mobilitazione record dopo l’annullamento delle elezioni del 2024, in seguito alla decisione della Corte Costituzionale di invalidare il voto. Quella decisione ha generato manifestazioni di protesta in diverse città della Romania, inclusa la diaspora, il clima politico è cambiato radicalmente e questa evoluzione è avvenuta in un contesto politico molto teso. Come è noto, per esempio per gli ebrei, col termine diaspora si indica la dispersione di una parte di un popolo o di una comunità etnica, religiosa o nazionale al di fuori del proprio paese d’origine, spesso per migrazioni dovute a persecuzioni o motivi economici. Nel linguaggio comune, quando si parla della “diaspora romena”, ci si riferisce ai romeni che vivono e lavorano all’estero, fuori dalla Romania – come in Italia, Spagna, Germania, Regno Unito. Le elezioni del 2024 segnano un momento di svolta per la Romania, mettendo in luce il potere della diaspora come forza determinante per il cambiamento. Con un numero crescente di cittadini romeni all’estero che esercitano il diritto di voto, il messaggio è stato chiaro: la comunità romena internazionale non è più un semplice spettatore, ma un protagonista attivo delle scelte politiche del Paese di origine. Il voto della comunità romena all’estero ha giocato un ruolo determinante, contribuendo in modo decisivo alla scelta dei candidati che si sono sfidati nel secondo turno. Lo scrutinio presidenziale del 4 maggio 2025 ha segnato una mobilitazione senza precedenti tra i rumeni della diaspora. Le comunità romene all’estero si sono presentate numerose alle urne, dimostrando un coinvolgimento civico sempre più attivo e un chiaro desiderio di influenzare la direzione politica del paese. L’annullamento delle elezioni del 2024 è stato percepito da molti come una reazione diretta a ciò che una parte dell’elettorato ha considerato una decisione abusiva o ingiustificata. Un voto di protesta o una scelta strategica? La crescita spettacolare dell’AUR (partito Alleanza per l’Unione dei Romeni) nella diaspora solleva domande essenziali sulla direzione verso cui si stava dirigendo l’elettorato romeno al di fuori dei confini. Se in passato il voto della diaspora era associato principalmente al sostegno di candidati europeisti e riformisti, ora sembra riflettere un reindirizzamento verso posizioni nazionaliste e antisistema. Le elezioni del 2025 rimangono un punto di svolta non solo per la scena politica interna, ma anche per comprendere la dinamica e l’influenza della diaspora romena nelle principali decisioni del paese.
Comunitatea
Cum au votat alegătorii români la ultimele alegeri
Participarea alegătorilor a fost ridicată, iar direcția votului a marcat o cotitură semnificativă În Italia, unde se află cea mai mare comunitate română din afara țării, cu peste un milion de persoane, au votat cu peste 50.000 de persoane mai mult decât în toamna trecută. În noiembrie 2024, la primul tur, au fost puțin peste 123.000 de alegători, în timp ce pe 4 mai 2025 au mers la urne aproape 175.000 de alegători. La „Diaspora română” a avut o mobilizare record după anularea alegerilor din 2024, ca urmare a deciziei Curții Constituționale de a invalida votul. Această decizie a generat manifestații de protest în diferite orașe din România, inclusiv în diasporă, clima politică s-a schimbat radical și această evoluție a avut loc într-un context politic foarte tensionat. După cum se știe, de exemplu pentru evrei, termenul diaspora se referă la dispersia unei părți a unui popor sau a unei comunități etnice, religioase sau naționale în afara țării de origine, adesea din cauza migrațiilor cauzate de persecuții sau motive economice. În limbajul comun, atunci când se vorbește despre „diaspora română”, se face referire la românii care trăiesc și lucrează în străinătate, în afara României – cum ar fi în Italia, Spania, Germania, Regatul Unit. Alegerile din 2024 marchează un moment de cotitură pentru România, evidențiind puterea diasporei ca forță determinantă pentru schimbare. Cu un număr tot mai mare de cetățeni români din străinătate care își exercită dreptul de vot, mesajul a fost clar: comunitatea română internațională nu mai este un simplu spectator, ci un protagonist activ în alegerile politice ale țării de origine. Votul comunității românești din străinătate a jucat un rol determinant, contribuind decisiv la alegerea candidaților care s-au confruntat în turul al doilea. Scrutinul prezidențial din 4 mai 2025 a marcat o mobilizare fără precedent în rândul românilor din diaspora. Comunitățile românești din străinătate s-au prezentat în număr mare la urne, demonstrând un angajament civic din ce în ce mai activ și o dorință clară de a influența direcția politică a țării. Anularea alegerilor din 2024 a fost percepută de mulți ca o reacție directă la ceea ce o parte a electoratului a considerat o decizie abuzivă sau nejustificată. Un vot de protest sau o alegere strategică? Creșterea spectaculoasă a AUR (partidul Alianța pentru Uniunea Românilor) în diaspora ridică întrebări esențiale cu privire la direcția în care se îndrepta electoratul român dincolo de granițe. Dacă în trecut votul diasporei era asociat în principal cu susținerea candidaților europeniști și reformiști, acum pare să reflecte o redirecționare spre poziții naționaliste și antisistem. Alegerile din 2025 rămân un punct de cotitură nu doar pentru scena politică internă, ci și pentru înțelegerea dinamicii și influenței diasporei române în principalele decizii ale țării.
L’ambiente
I pini sotto attacco: la cocciniglia Toumeyella parvicornis minaccia anche Sacrofano
Il nostro territorio è ufficialmente classificato come zona infestata: necessario intervenire per proteggere il patrimonio arboreo
di Simone Bianchini, agronomo
Negli ultimi anni, i pini domestici (Pinus pinea), parte fondamentale del paesaggio laziale e simbolo dell’identità storica del territorio, sono sotto l’attacco costante di un piccolo ma aggressivo insetto: la cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), così chiamata per la caratteristica morfologia del corpo delle femmine adulte, che ricorda il carapace di una tartaruga. Se in un primo momento il problema sembrava circoscritto alle aree più urbanizzate della Capitale, oggi coinvolge direttamente anche il nostro Comune. Dal 2023, infatti, Sacrofano è ufficialmente classificato come zona infestata secondo la normativa fitosanitaria regionale. Nel 2021, il territorio comunale di Sacrofano era stato inserito nella cosiddetta zona buffer o “cuscinetto”, area intermedia tra zone infestate e zone ancora indenni. Tuttavia, il progressivo avanzamento dell’infestazione ha reso necessario, nel 2023, l’aggiornamento della classificazione: Sacrofano è oggi riconosciuta come zona infestata dalla Toumeyella parvicornis. Originaria del Nord America, la Toumeyella parvicornis è un insetto fitomizo appartenente alla famiglia Coccidae. Dopo la sua prima segnalazione nell’areale romano nel 2018, si è diffusa molto rapidamente, trovando nel clima mite del Lazio e nell’assenza di antagonisti naturali un ambiente ideale per il suo insediamento. L’insetto si nutre della linfa, localizzandosi sui giovani rametti e producendo abbondante melata, sostanza zuccherina che ricopre aghi e tronco, favorendo la formazione di fumaggine. Le piante colpite manifestano sintomi gravi, tra cui: l’ingiallimento diffuso della chioma; copiose colature resinose e appiccicose e quando non curate sofferenza cronica, che può portare a un deperimento irreversibile. Per contrastare la Toumeyella parvicornis, l’approccio più efficace e sostenibile è rappresentato dai trattamenti di endoterapia, che consistono nell’iniezione di principi attivi direttamente nel tronco dell’albero. Questa tecnica, a basso impatto ambientale, consente di colpire l’insetto in modo mirato, riducendo al minimo la dispersione di sostanze chimiche nell’ambiente circostante. Poiché l’insetto attacca anche pini in giardini e aree verdi private, è essenziale il coinvolgimento diretto dei cittadini. In presenza di pini sofferenti, con aghi ingialliti o presenza evidente di melata e fumaggine, si consiglia di contattare tempestivamente un tecnico agronomo e/o una ditta specializzata per effettuare i relativi trattamenti di endoterapia. La presenza della cocciniglia tartaruga nel territorio di Sacrofano non è più un’ipotesi remota, ma una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Intervenire in modo tempestivo e mirato è oggi indispensabile per evitare danni irreversibili al patrimonio arboreo locale. La salute dei nostri pini, spesso esemplari maestosi e centenari che impreziosiscono il paesaggio con la loro imponenza e bellezza, va tutelata con interventi mirati e tempestivi.

Restaura/azione
Il monumento ai caduti di Sacrofano
di Alessia Felici
Un fante, sentinella immobile che imbraccia il fucile, le mani nascoste per il freddo, avvolto in un pesante e rigido pastrano, rappresentato come se fosse sulle rocce del Carso, rese in travertino sbozzato. Il bronzo, una volta scuro e nero, è ormai slavato e bluastro e la pietra è scurita e ingiallita dal tempo. Sul prospetto che guarda lungo via IV Novembre si trova una lastra bronzea con un bassorilievo, una figura femminile reclinata che tiene nella mano sinistra un ramo di alloro e nella destra una fiaccola accesa. Al di sotto una fiaccola votiva. Sul cippo in travertino sono incisi 16 nomi di caduti distinti per cause di morte. Sul fronte del basamento in pietra, in caratteri romani è riportata la data: MCMXV – MCMXVIII Sul lato opposto una scritta recita: 8 set. 1921 AI CARI FIGLI MORTI PER LA PATRIA – SCROFANO ROMANAMENTE VOLLE – NELLA SUA TERRA ERETTO IL MONUMENTO ONORARIO – NEL CUORE DEI VIVI E DEI VIVENTI NEI SECOLI – L’ALTARE DELLA MEMORIA L’autore del monumento fu Torquato Tamagnini. L’abbreviazione “TT” del nome e del cognome si trova sul prospetto esterno del basamento in travertino, rivolto sulla via principale, in basso, a destra dell’iscrizione della data in caratteri romani. Torquato Tamagnini nasce a Perugia nel 1886. Si trasferisce a Roma e vince il Pensionato artistico nazionale. Riscuote grande successo presso la nobiltà romana dedicandosi alla ritrattistica, medaglie e bronzetti. E’ rinomato soprattutto per la realizzazione di monumenti ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Prima del 1922 fonda a Roma la Corinthia, casa d’arte per la scultura. Le case d’arte erano “ditte” che proponevano monumenti già pronti o realizzati in breve tempo, offrendo ai committenti a volte cifre più accessibili rispetto ai prezzi richiesti dagli scultori affermati. Se ne contano un centinaio in tutta Italia. (La memoria perduta. I monumenti ai caduti della Grande Guerra a Roma e nel Lazio. A cura di Vittorio Vidotto, Bruno Tobia, Catherine Brice. Argos. 1998.) Ogni anno la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, presenta un bando per l’assegnazione di “Contributi a progetti ed iniziative relativi al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale”. Anche il nostro Comune vi ha partecipato, ma l’assegnazione dei contributi prevede un cofinanziamento ed un progetto “di qualità”. L’omaggio più dignitoso per i nostri caduti.

Idee
Il teatro non è un evento, è una rete vitale
Idee per l’Ilaria Alpi di Sacrofano come parte integrante di un circuito intercomunale
di Adriano Braidotti, autore e curatore culturale
Il teatro oggi non può più essere intrattenimento. L’intrattenimento è ovunque: sugli smartphone, nei supermercati, nei social, nei dialoghi vuoti. Il teatro, se vuole sopravvivere, deve tornare ad essere missione. Resistenza. Presidio civile. C’è bisogno di una rete che leghi e unisca lo sforzo della cultura almeno dei paesi limitrofi. Una rete teatrale tra comuni non può nascere solo per “fare spettacoli”. Deve sorgere dalla necessità di creare luoghi per le idee. Idee che viaggino, che si sviluppino, che incontrino la carne viva delle persone. Un’idea, per vivere, ha bisogno di passare di bocca in bocca. Di paese in paese. Non serve che una compagnia produca uno spettacolo per replicarlo due volte e sparire. Serve sapere che quello spettacolo può circuitare, attraversare, connettere. Che può arrivare ad esempio da Formello a Morlupo, da Riano a Sacrofano, da Campagnano a Castelnuovo. Che può trasformare una sala eventi, una biblioteca, una palestra, in uno spazio di parola e coscienza. L’Italia è ancora un paese feudale. Ogni borgo ha i suoi ritmi, i suoi linguaggi, le sue chiusure. Eppure siamo nel tempo della globalizzazione. Posso parlare con Tokyo, ma non portare uno spettacolo a 7 km da casa? Il teatro deve tornare ad essere ponte, aggregatore, detonatore. È più antico di ogni religione. Più radicale di ogni partito. La Chiesa l’ha capito: ha preso un format teatrale e lo replica sui suoi palchi ogni domenica. Quello era (ed è) teatro. Il teatro è anche un antidoto al cinismo. È lo spazio dove si può ancora parlare senza urlare, dove si può ancora piangere senza vergogna. È il laboratorio in cui un popolo si rifonda, pezzo per pezzo, voce per voce. Una rete teatrale tra comuni non è solo un progetto culturale: è un gesto politico, concreto e visionario. È dire: “noi ci siamo ancora”. È creare legami, occasioni, movimento. È impedire che ciò che nasce muoia dopo una replica. È dare ossigeno a chi ha qualcosa da dire e terra a chi ha bisogno di ascoltare. Riprendiamoci i luoghi. Ricominciamo a parlare. Ricominciamo dal teatro. 

Cerbottana
Una volta, gli italiani a tavola parlavano di quello che avevano mangiato. Oggi di quale dieta stanno facendo.
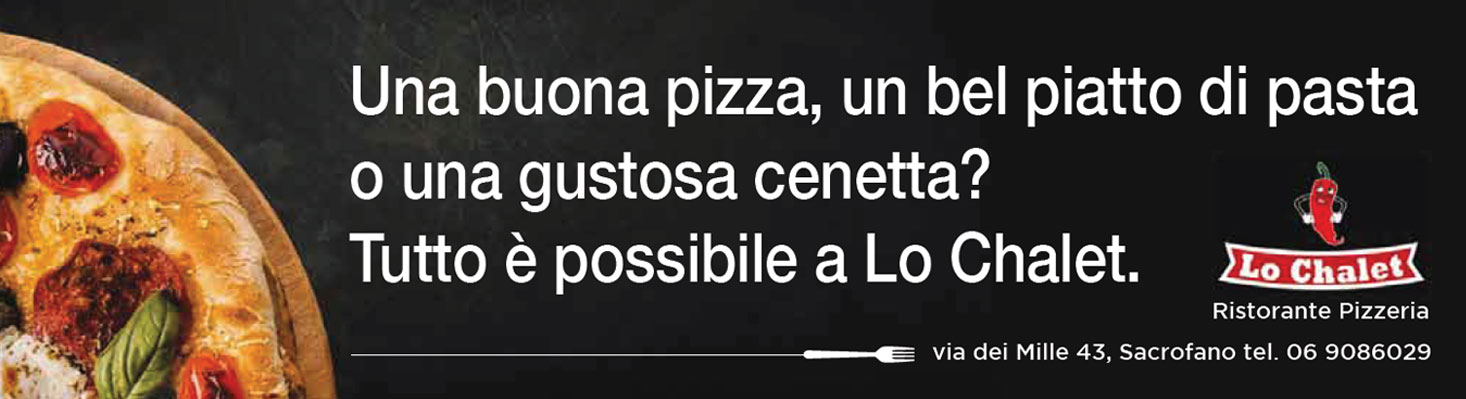
Territorio
Discarica a Magliano? No, grazie
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta una vittoria per le comunità locali e le associazioni ambientaliste Il Consiglio di Stato ha bloccato la discarica di Magliano Romano con la sentenza n. 3997 del 9 maggio 2025, accogliendo le preoccupazioni del Comune e delle associazioni ambientaliste riguardo a gravi criticità ambientali e sanitarie legate al sito. Anche il Comune di Sacrofano si era mobilitato contro la discarica. La discarica si trova all’interno del Parco di Veio e in prossimità del bacino idrogeologico del Parco del Treja, aree di elevato valore ecologico e naturalistico. La sua ubicazione vicino a zone protette e a fonti di approvvigionamento idrico ha amplificato le preoccupazioni riguardo ai potenziali impatti ambientali e sanitari. La sentenza ha evidenziato un aumento significativo della concentrazione di fluoruri nelle falde acquifere rispetto ai dati precedenti all’attivazione della discarica. Questo incremento è stato ritenuto preoccupante per la salute pubblica e l’ambiente, soprattutto considerando la vicinanza a pozzi per l’acqua potabile. Non solo. Il Consiglio di Stato ha riscontrato l’assenza di un modello idrogeologico aggiornato e affidabile, necessario per comprendere l’estensione della contaminazione e la sua correlazione con l’attività della discarica. In sostanza, la sentenza ha annullato le deliberazioni regionali del 2016 e 2022 che autorizzavano deroghe fino al 300% sui limiti di inquinanti nei rifiuti conferiti e prevedevano l’ampliamento della discarica, ritenendole incompatibili con la tutela ambientale. Ma non finisce qui. A seguito della sentenza, l’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No Discarica Magliano Romano ha inviato una diffida alla Regione Lazio, chiedendo la revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2013 per la gestione della discarica. La richiesta è stata indirizzata anche alle Procure di Roma e Tivoli, all’ISPRA, all’AUSL, alla Città Metropolitana di Roma, alla Commissione PETI del Parlamento Europeo e ai comuni limitrofi. In definitiva, si tratta di una vittoria significativa, che pone un freno a un progetto ritenuto incompatibile con la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.

Uomini e animali
Un’estate da cani
Con l’arrivo della stagione estiva uno dei pericoli per i quali occorre fare più attenzione è la sopraggiunta dei forasacchi
di Alessandro Floris, veterinario

I forasacchi sono semi di graminacee selvatiche, nello specifico di orzo e avena selvatici (ma non solo). Tra aprile e maggio e tra agosto e settembre le graminacee rilasciano questi loro semi in grandi quantità. Perché costituiscono un pericolo per i nostri cani? Perché possono provocare lesioni cutanee, in quanto la loro forma appuntita può impigliarsi tra la peluria infilandosi nell’epidermide, negli orifizi, negli spazi interdigitali, nelle orecchie… Se non vengono prontamente rimossi, i forasacchi possono penetrare nella cute‚ provocando infezioni anche serie. Il grande pericolo è rappresentato dalle LESIONI POLMONARI. I forasacchi possono essere aspirati durante la respirazione a bocca aperta mentre i nostri amici a quattro zampe corrono e giocano all’aria aperta. Il forasacco inspirato può arrivare direttamente nelle vie respiratorie medie e anche profonde provocando infezioni polmonari e setticemie gravi. Questa tipologia di eventi risulta difficile da diagnosticare perché si manifestano solo nella fase acuta della patologia o nella fase terminale. Un altro allarme è rappresentato dalle lesioni alle narici: la condizione per la quale il forasacco viene annusato dal cane penetrando all’interno dei condotti nasali, provoca violenti starnuti che non passano inosservati e richiedono un immediato intervento del veterinario. Ai già elencati problemi si aggiungono le lesioni delle orecchie: questa localizzazione è tipica ma meno pericolosa, in quanto il forasacco si posiziona all’interno del condotto auricolare provocando lo scuotimento della testa unito a fenomeni di grattamento insistente, senza però provocare danni più seri. Le lesioni degli occhi, al contrario, sono molto più evidenti in quanto il cane presenta una violenta lacrimazione unita a occhi gonfi, arrossati e blefarospasmo (tendenza a tenere chiuso l’occhio.
Come prevenire il problema e quando è opportuno rivolgersi al veterinario? Possiamo fare molto in termini di prevenzione. Per prima cosa è opportuno evitare luoghi in cui l’erba è eccessivamente alta e incolta. Importante è anche ispezionare il nostro cane al rientro della consueta passeggiata. Questa attenzione permette di verificare la presenza di queste ariste così pericolose prima che possano far danni. Trovare le spighe in tempo appoggiate sul pelo, intorno alle orecchie, agli occhi, sotto la coda, tra le dita delle zampe, consente una rimozione immediata. Tutte le volte in cui notiamo starnuti ricorrenti, fistole cutanee, blefarospasmo negli occhi e scuotimento continuo della testa, occorre rivolgersi a un veterinario perché l’asportazione presuppone un livello di intervento specialistico in alcuni casi con sedazione. L’intervento deve essere eseguito da un medico veterinario. Per concludere va sottolineato che i forasacchi possono apparire un problema banale ma rappresentano una concreta e reale minaccia per la salute dei nostri cani. Come si è sempre detto nella storia della medicina la prevenzione è sempre la migliore arma a nostra disposizione. Controlliamo sempre il nostro amico cane. Proteggiamo i nostri amici durante l’estate, donando loro amore, cura e attenzione.
La ricetta del mese
La Panzanella
di A I
Nota fin dal XVI secolo, grazie al Bronzino (1503-1572), pittore manierista e poeta fiorentino, la panzanella deve il suo nome da un gustoso neologismo formato dalla parola “pane” e dal sostantivo “zanella”, che in toscano antico voleva dire scodella. La panzanella semplice si fa con pane secco bagnato con acqua, condito con aceto, olio d’oliva, sale, prezzemolo o basilico e “erba pepe”, cioè santoreggia. Ma si può fare della panzanella un vero e proprio piatto da portata. Prendiamo mezza galletta a persona. Si spezza e si bagna con acqua e aceto, si appallottola con le mani e si condisce con sale, pepe, basilico, prezzemolo, capperi e un bel filo di olio extravergine di oliva, quello di Sacrofano. La poltiglia si adagia su piatto da portata e si guarnisce con un pesto di acciughe, una punta d’aglio, un assaggio di peperoncino, il tutto mescolato con aceto e un filo d’olio. E l’estate diventa più buona. P.S.: nell’antica ricetta non era previsto il pomodoro, che invece è stato aggiunto dal XIX secolo ai nostri giorni


Servizi
A Sacrofano sono circa mille i cittadini che si rivolgono al CAF
Gestito da Eleonora Colasuonno, da 10 anni il Caf di Sacrofano prende in carico problematiche fiscali e pensionistiche. Le domande di invalidità sono il 20 per cento, e riguardano anche i giovani
di M. F.

Di formazione umanistica, con una predilizione per la filosofia, Eleonora Colasuonno a un certo punto della sua vita decide di dedicarsi agli altri, agendo attraverso un Centro di assistenza fiscale. I CAF sono nati in Italia nei primi anni Novanta, a seguito della riforma fiscale introdotta dal Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, anche se la loro introduzione operativa risale a qualche anno prima, con la Legge n. 413 del 30 dicembre 1991. È tra il 1993-1995 che inizia la loro effettiva attività sul territorio. Poi, appunto, grazie al D.Lgs. n. 241/1997 i CAF ridefiniscono e consolidano il loro ruolo all’interno del sistema fiscale italiano, soprattutto con l’introduzione del modello 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati. Ciò che attira l’attenzione e poi l’attività di Colasuonno è la possibilità di partecipare a un vero e proprio cambiamento dei rapporti tra i cittadini e quella che spesso con una certa diffidenza, per non dire disprezzo, viene definita “burocrazia”. Infatti, con i Caf, si è realizzata in parte la semplificazione fiscale, che ha permesso ai cittadini e ai lavoratori di adempiere agli obblighi fiscali senza rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’Introduzione di modelli dichiarativi semplificati (es. 730) ha permesso l’assistenza di esperti come, appunto, Colasuonno. Con i Caf si è, poi, realizzata la decongestione degli uffici pubblici, alleggerendo il carico di lavoro dell’Agenzia delle Entrate e delegando l’assistenza fiscale. Il risultato è stata una maggiore correttezza e controllo: il fatto che il servizio fornito dai Caf fosse controllato e certificato ha aumentato la sicurezza per l’utente. È stata così creata una rete capillare su tutto il territorio nazionale, spesso legata a sindacati o associazioni di categoria, che potesse assistere anche le fasce più deboli o meno digitalizzate. Il Caf di Eleonora Colasuonno ha la sede principale a Sacrofano e un ufficio anche a Campagnano. Si occupa di più di mille utenti, fra lavoratori e pensionati, ma le fasce sociali dei suoi assistiti sono più estese, perché coinvolgono anche altre categorie di cittadini, basta dare un’occhiata ai servizi offerti. In particolare: compilazione e invio del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi; compilazione del Modello Redditi (ex Unico); calcolo e pagamento di IMU e TASI; ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere a prestazioni sociali agevolate; bonus sociali (luce, gas, acqua); contratti di locazione agevolati, successioni, colf e badanti, ISEU per università. Recentemente, ci fa notare Eleonora Colasuonno, si registra un aumento di casi di invalidità civile, che raggiunge quasi il 20 per cento dei suoi assistiti, anche in giovane età, a causa di patologie invalidanti. Quello che colpisce di Eleonora, come la chiamano tutti confidenzialmente, è il suo atteggiamento sereno, sorridente e conciliante, come se affrontare quell’Idra con molte teste che è la burocrazia italiana non la preoccupasse, sicura della sua capacità di resilienza per risolvere anche i problemi più complessi dei suoi utenti.
Hair Beauty
Alla luce del sole
Consigli per goderti il sole senza compromettere la bellezza e la salute dei tuoi capelli colorati
Di Emanuele Bruschi
Trattare i capelli colorati esposti al sole richiede attenzione e cura per preservare la loro brillantezza e salute. I raggi UV, il calore e l’umidità possono danneggiare e sbiadire il colore, rendendo essenziale adottare una routine di protezione adeguata. La prima regola per proteggere i capelli colorati è scegliere prodotti specifici che contengono filtri solari. Molti shampoo, balsami e trattamenti leave-in sono formulati per schermare i capelli dai danni dei raggi UV. Il sole, insieme al calore, può seccare i capelli, rendendoli fragili e opachi. È fondamentale mantenere un’idratazione costante. Usa maschere nutrienti e balsami idratanti almeno una volta a settimana per mantenere i capelli morbidi e lucenti. Applicare oli leggeri o sieri specifici per capelli colorati prima di esporsi al sole può offrire una protezione aggiuntiva. Questi prodotti aiutano a formare una barriera contro i raggi UV e l’umidità, riducendo l’effetto di secchezza. Limitare l’uso di strumenti di styling ad alta temperatura, come piastre e arricciacapelli, può ridurre ulteriormente i danni. Il calore del sole unito a quello degli strumenti di styling può compromettere ulteriormente la salute dei capelli. Se hai nuotato in piscina o al mare, è buona norma sciacquare i capelli con acqua dolce subito dopo. Questo aiuta a rimuovere cloro o sale, che possono danneggiare ulteriormente il colore e la struttura dei capelli. Rivolgiti a un parrucchiere esperto per consigli personalizzati e prodotti adatti al tuo tipo di capelli. Infine, presta attenzione ai segnali dei tuoi capelli. Se noti secchezza, fragilità o sbiadimento del colore, potrebbe essere il momento di rivedere la tua routine di cura e investire in prodotti di alta qualità e trattamenti specifici. Seguendo questi consigli, puoi goderti il sole senza compromettere la bellezza e la salute dei tuoi capelli colorati. Una cura adeguata garantirà capelli splendenti e protetti, anche nelle giornate più soleggiate.

Le persone
Anna, la maestra della sua vita

La prima donna assunta in RAI con la mansione di montatore nel 1996, Anna Lorena Brindisi vive a Sacrofano dal 2001. Originaria di Potenza è stata maestra elementare nella sua città, insegnante Isef a Milano, prima di vincere il concorso a Roma e diventare montatrice per RAI. “Dovevo essere destinata al TG 1, ma non mi vollero perché ero donna”, ricorda Anna, che poi però è diventata capo montatore al TG3. Così come nel cinema, tutti coloro che con la tv diventano volti noti al pubblico lo devono a professioniste come Anna e i suoi colleghi, preparati, competenti e creativi che non appaiono, ma è il loro lavoro il vero protagonista di tutto il processo produttivo della messa in onda dei programmi televisivi.
Le persone
È la pasticceria, dolcezza

Valentina Scuccimarra, la pasticcera di “Cattive compagnie”, è a Sacrofano dal 1985. “A mettere la mani in pasta l’ho imparato da mia madre, che faceva i tortellini in casa”, dice Valentina che poi ha studiato presso “Les Chefs Blancs” e imparato a fare prodotti da forno lavorando accanto ad artigiani da cui ha appreso preziosi segreti del mestiere. Fino ad aprire “Mille voglie” pasticceria in piazza XX Settembre, chiusa dal Covid. Ora crea e sforna piccole e gustose leccornie per la gioia del palato dei clienti di “Cattive compagnie”.
Le persone
Il corriere prima della sera

Nicola Giordano lavora su e giù per le strade di Sacrofano da circa sei anni, dalla mattina alla sera. “Prima del Covid consegnavo una trentina di pacchi al giorno. Oggi sono più di cento, che sotto le feste diventano almeno 130”. Nicola conosce tutti ed è conosciuto da tutti, perché ha una forte empatia, il suo cellulare è una specie di call center, cui i clienti si rivolgono per agevolare le consegne. La sua comunicativa è quel prezioso valore aggiunto che gli permette di mettere a loro agio i clienti cui consegna tutti i giorni pacchi di ogni grandezza e importanza. Tutti aspettano che Nick suoni alla loro porta.
Sport
Che cosa e come fare perché a Sacrofano lo sport sia accessibile a tutti?
In vista della prossima riapertura della piscina comunale e dei campi sportivi a Monte Sarapollo si pone il problema di come fare rete con altre strutture attrezzate sul territorio, perché le attività sportive siano accessibili e fruibili da tutti
Di L. B.
Come abbiamo sottolineato nello scorso numero del giornale, i finanziamenti del Pnrr, con l’aggiunta dei fondi stanziati dalla Città Metropolitana per rimodernare e rendere efficiente le strutture sportive di Monte Sarapollo sono senza dubbio una buona notizia. Tuttavia, è necessario aprire un dibattito a proposito del rapporto tra l’offerta di spazi pubblici attrezzati e la domanda di partecipazione alle attività sportive non solo degli appassionati, ma anche delle persone più fragili, dibattito stimolato dagli stessi discorsi inaugurali dei lavori da parte della Sindaca Patrizia Nicolini e del Vicesindaco delle Città Metropolitana, Pierluigi Sanna. La vera sfida, però, non si esaurirà con la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti del polo sportivo ma sarà quella di renderlo fruibile per la popolazione e sostenibile nella gestione. Fruibile implica fare in modo che la maggior parte della popolazione possa accedervi per praticare attività sportiva con facilità e sicurezza. Il fatto che tale area non sia raggiungibile dal paese se non con mezzi privati non va sicuramente in questa direzione; un potenziale disincentivo per una (piccola?) parte della popolazione all’utilizzo delle nuove strutture – se comunque devo prendere la macchina per portare mio figlio alla scuola calcio tanto vale che scelga la migliore tra quelle dei paesi limitrofi, non necessariamente quella del mio paese – . Il territorio comunale è tale per cui per una discreta porzione dei residenti rischia di essere più comodo recarsi a Roma dove l’offerta è di gran lunga superiore, anche presso strutture private, piuttosto che usufruire di una qualsiasi delle attività offerte dalla realtà locale. Un polo sportivo isolato dal contesto urbano, quindi meno fruibile, rischia di perdere attrattività. Sostenibilità è l’altra parola chiave quando ci riferiamo a impianti sportivi che comportano ingenti investimenti da parte dell’amministrazione pubblica perché, al di là dei costi di realizzazione (a prescindere da quale tasca provengano), la vera sfida è rendere tali opere funzionanti e funzionali nel tempo. Questo può avvenire solo se si raggiunge un equilibrio economico tra costi di gestione ed entrate e, in tempi di costi di energia altalenanti e contrazione demografica, trovare questo bilanciamento è tutt’altro che scontato. Il rischio che si annida dietro la realizzazione di questo tipo di opere è che una volta completate o restaurate ed inaugurate non si riesca ad offrirle alla cittadinanza per quella che dovrebbe essere la loro natura: non un semplice vanto per il paese ma uno strumento atto a garantire il diritto alla pratica sportiva e quindi alla salute, nel corso del tempo. Sarebbe auspicabile in questo senso effettuare una panoramica sull’offerta sportiva del territorio in senso ampio; coinvolgendo nell’analisi i comuni limitrofi per capire come modulare offerta, individuare possibili sinergie con altre società sportive o amministrazioni, inventarsi servizi accessori al fine di elaborare un’offerta sportiva appetibile che garantisca qualità e continuità nel tempo. Insomma, bisognerebbe cominciare a progettare un sistema, a fare rete. Questo per evitare il rischio ‘cattedrale nel deserto’: impianti di alto livello con costi di gestione troppo alti rispetto all’attrattività, combinazione, questa, che sancirebbe il fallimento sul medio periodo del progetto polo sportivo.

Abbiamo chiesto a Toni Scattolon, (nella foto di Romeo Mancori) assessore con delega allo sport, quale progetto sta prendendo forma a Monte Sarapollo e quali ricadute potrà avere sulla socialità, ma anche sull’economia di Sacrofano. L’intervisrta sarà pubblicata nel prossimo numero di La Nuova Sacrofano.